 Quando si parla di cinema spagnolo d’autore, soprattutto se si considera solo la prima metà del novecento, l’unico autore che solitamente viene alla memoria è Luis Bunuel e sul muto la storia sembra cominciare nell’anno in cui il muto sta per finire: il 1929 con Un chien andalou. Quella spagnola è certamente una cinematografia minore, con risultati ben lontani, in Europa, da Francia, Germania, Italia e paesi scandinavi, ma basta – come sempre in questi casi – cercare meglio, non fermarsi alle filmografie consigliate, per scoprire dei piccoli capolavori che, se studiati a dovere, non hanno nulla da invidiare ai capisaldi del genere.
Quando si parla di cinema spagnolo d’autore, soprattutto se si considera solo la prima metà del novecento, l’unico autore che solitamente viene alla memoria è Luis Bunuel e sul muto la storia sembra cominciare nell’anno in cui il muto sta per finire: il 1929 con Un chien andalou. Quella spagnola è certamente una cinematografia minore, con risultati ben lontani, in Europa, da Francia, Germania, Italia e paesi scandinavi, ma basta – come sempre in questi casi – cercare meglio, non fermarsi alle filmografie consigliate, per scoprire dei piccoli capolavori che, se studiati a dovere, non hanno nulla da invidiare ai capisaldi del genere.
Uno di questi è Il villaggio maledetto (titolo originale La aldea maldita) scritto e diretto da Florian Rey, girato nel ’29 e circolato l’anno successivo prevalentemente in Spagna e in Francia, dove ebbe un discreto successo. Al centro della vicenda c’è un piccolo villaggio della Castiglia dove negli ultimi anni il clima difficile ha distrutto quasi tutto il raccolto. Gli abitanti credono ormai che sia l’effetto di una maledizione, i più devoti la attribuiscono ad una mancanza di sincera fede religiosa. I campi di Juan, onesto e virtuoso contadino, sono ridotti così male che non porteranno frutto e, senza riserve, le uniche prospettive sono la fame e la miseria. Juan ha sulle sue spalle il vecchio padre cieco e suo figlio, appena nato, oltre la moglie Acacia; è disperato e non appena sa che il signorotto del paese, Zio Lucas, ha scorte ingenti di cereali che vuol tenere tutte per sé, reagisce in malo modo e viene arrestato.
Proprio durante i suoi giorni di prigionia l’intero paese decide di emigrare, in cerca di fortuna e terre più fertili. Tra questi c’è anche Acacia che deve prendere una decisione per sé e per suo figlio, senza poter consultare Juan. Influenzata da un’altra donna, sua amica, che le fa sognare la vita di città, il lusso e le ricchezze possibili lontano dal villaggio, sceglie di partire, ma il suocero non le permette di portare con sé il piccolo neonato. Con la prospettiva di tornare non appena avrà accumulato una discreta somma di denaro si unisce alla carovana, lunga e apparentemente interminabile, che svuota il villaggio. Colto da un sentimento improvviso di pietà Zio Lucas libera Juan, ma Acacia è già partita. Accettando la separazione e confidando nella fedeltà della moglie anche Juan lascia il villaggio col padre e il figlio. Tre anni dopo per puro caso Juan trova Acacia, in compagnia della sua amica, in una locanda dei bassifondi: crollata ogni illusione i due intraprendono una vita di apparenze per salvare la faccia agli occhi del vecchio padre che vede nell’onore e nella rispettabilità l’unica ricchezza di famiglia. Dapprima saranno interdetti contatti di ogni tipo tra il figlio e la madre ritrovata, ma il perdono saprà farsi strada nel cuore di Juan.
Quello di Rey è indubbiamente un film edificante, secondo i canoni piuttosto in voga del tempo, tant’è che oggi, più che la trama o il finale alquanto scontato, l’interesse è tutto per la forma, la messa in scena, la fotografia, l’uso figurativo dei personaggi e gli effetti speciali. Ciò assume ancora più valore e interesse se si considera che all’epoca spopolavano gli adattamenti e i tentativi di acquistare fama e onore nell’ambito delle arti tradizionali. Ne Il villaggio maledetto è invece il cinema a vincere sulla letteratura e per questo il film è tuttora pienamente godibile e per la sua forza appare come un passaggio doveroso per ogni appassionato del genere. Sono qui visibili in luce tutti gli elementi che poi diverranno la sostanza del melodramma europeo del secondo dopoguerra: i valori messi in pericolo, le passioni, i sentimenti impetuosi, le lacrime, i legami famigliari.
Sembra già di vedere all’orizzonte certi film di Matarazzo e Cottafavi e il volto risoluto di Amedeo Nazzari oppure, in Francia, i film con Jean Gabin o, in Germania, le opere di Helmut Kautner. Proprio la significatività retrospettiva di quest’opera convinse forse l’autore a proporne un rifacimento nel 1942, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, in cui Rey aggiunse molta più dinamicità e visionarietà alla vicenda – la scena dell’esodo forzato è un esempio di prim’ordine di poesia cinematografica – ma perde un po’ della sua asciuttezza, del suo equilibrio e dell’essenzialità che solo il muto e il linguaggio del muto confluito nel cinema sonoro sanno dare. D’altro canto bisogna considerare come già nel 1930 fu proposto a Rey di realizzare una doppia versione muta e sonora del film, forse per indirizzarla su mercati già conquistati dal fragore dei talkies. A edizione muta già completata Rey girò alcune scene alternative in Francia e integrò il doppiaggio sul film già montato, con risultati ben poco soddisfacenti come lui stesso ammise. Oggi non possiamo giudicarli poiché le poche copie sonore sono andate perdute. Resta lo splendore del muto, i giochi di luce degni del miglior espressionismo tedesco, attori sfavillanti nella loro economia espressiva e scene corali che risentono dell’influenza sovietica.
Il villaggio perduto è un altro di quei film usciti dal canone, e per questo poco visti e poco visitati, che andrebbero ridiscussi e reinseriti nei circuiti cinefili e culturali. Rey è l’unico dei primi autori spagnoli a non avere una pagina Wikipedia in italiano e ciò può significare moltissime cose e tutte ben precise.
Più passa il tempo qui su E muto fu e più emerge palese, sorprendente e affascinante l’esigenza di rivedere le filmografie di base, metterle in discussione e redigerne di nuove.
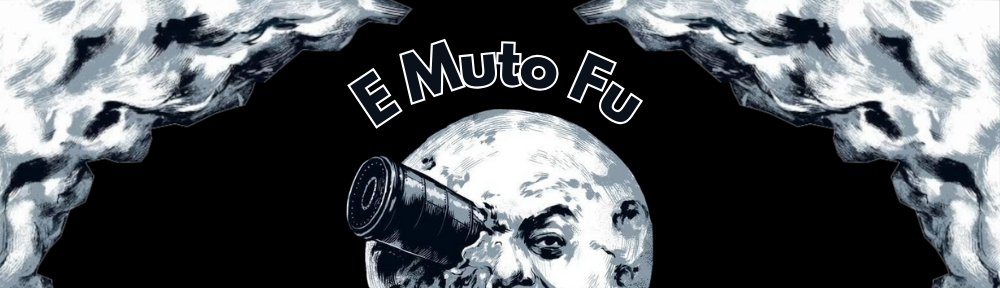













Bellissimo film. Ho avuto l’occasione di vederlo anni fa ad una rassegna a Madrid e mi fa un grande piacere ricordarlo grazie a voi. Continuate così, con questa stessa passione e con la competenza che dimostrate.
Un saluto.
Aldo Meiotti